Napoli è una città che i ricordi non li conserva con gelosia.
E’ una città che non fa pubblicità della sua storia, ma è generosa nel raccontarla, e ti fa balzare addosso le memorie di quelli che la storia l’hanno vissuta, mentre cammini per le strade che al titolo di centro storico ci sono arrivate per diritto.
Io queste zone le ho vissute per più di mezzo secolo, e le ho viste cambiare.
E i ricordi che sto qui a raccontare non sono il frutto della nostalgia che il disagio muove verso la compassione per se stessi, ma la conseguenza naturale dell’esperienza che mi riconosco, quando, guardandomi allo specchio, è la piena consapevolezza di ciò che ho fatto a muovere la compassione verso le generazioni che non hanno saputo costruirci molto sopra.
Ed io ho fatto il ’68. E il ’68 è caduto in piedi.
Ero iscritto alla facoltà di Architettura di Napoli, in quegli anni.
Palazzo Gravina era un luogo di grossi movimenti, il ciclostile stampava senza sosta i volantini con gli slogan del Collettivo universitario e delle sue componenti più ingerenti, Lotta Continua e Servire il Popolo.
Un ciclostile simile a quello che, non molti anni dopo, sarebbe stato usato per divulgare i più violenti manifesti delle Brigate Rosse.
L’idea che avevamo della vita era quella di una imprescindibile ribellione antisistema, che si collocava nella logica mondiale di estraneità da qualsiasi istituzione fondata sull’autoritarismo: lo Stato, la polizia, le baronie universitarie, gli industriali, la magistratura, la Chiesa.
Guardavamo con diffidenza anche al PCI e ai sindacati, strumenti del capitale, che confinava l’ideologia del fare al limite dei compromessi e dei contratti.
Ma eravamo dei ragazzi. Un gruppo eterogeneo di menti allenate al pensare, da gente dell’alta borghesia (per cui la ribellione rappresentava quasi la moda del momento) ai figli dei lavoratori, degli operai che combattevano nelle fabbriche per l’abolizione del cottimo, per l’aumento salariale uguale per tutti, per il diritto d’assemblea.
Ma per noi i termini della lotta non si chiarirono finché dal pensiero non si passò al progetto.
Finché dalle porte chiuse delle sedi occupate non si passò alla propaganda della violenza di risposta.
Mi ricordo che un pomeriggio di maggio eravamo riuniti in Assemblea. Si parlava di politica in modo confuso, passando da generiche riflessioni di sinistra alla critica del PCI.
Bevevamo vino, la coscienza della nostra influenza sulla gestione degli affari universitari ci rendeva euforici, e l’euforia si traduceva in una contestazione poco lucida di qualsiasi consuetudine amministrativa.
Un mio compagno entrò nella stanza con un sorriso d’eccitazione che non riuscivo a comprendere.
Nascondeva qualcosa sotto la maglietta rossa, qualcosa che qualche istante dopo lanciò sul tavolo, e che cadde con grande rumore fra il posacenere e la bottiglia.
Era una Walther P38.
“Questo è il simbolo della nostra rivoluzione”, urlò ai presenti.
Mi ricordo che fui spaventato. Non dalla presenza di un’arma da fuoco nella stanza, ma dalle possibilità che erano riassunte in quell’arma.
La mia rivoluzione era stata tutta nei libri dei filosofi che avevo letto: da Marx, a Mills, a Rosa Luxeburg. Mi sentivo feroce nel pacifismo della mia indole, perché avevo l’ingenua convinzione che si potesse fare la guerra con gli striscioni in mezzo alla piazze e nient’altro fra le mani.
La mia è la generazione di quelli che hanno pensato che la rivoluzione si potesse fare solo in gruppo. E’ la generazione che ha dimostrato quanta forza ci fosse nell’ostinazione della periferia del sistema, nelle classi che fino ad allora non avevano voce in capitolo in nulla.
La mia è la generazione che si è ubriacata del potere derivato dalle grandi perturbazioni, quello che sta nelle mani incoscienti di star facendo la storia mentre la fanno.
La stessa generazione che ha vissuto lo stordimento e la delusione della mattina dopo la sbornia, quando ci si è resi conto che la foga degli slogan non era solo l’espressione dell’entusiasmo del momento, ma la realtà di una prospettiva inevitabile.
Eppure abbiamo agito in nome della spontaneità che ha permesso alle generazioni successive di fruire di una emancipazione progressiva, di garantire un riscatto sociale dei deboli, degli esclusi.
La nostra politica ha tentato di scavalcare l’ordine naturale delle cose, traducendosi in aspettativa eversiva che giustificava le rivendicazioni violente.
Oggi, più di quarant’anni dopo, so che l’azione ha fallito dove non ha fallito l’idea.
E quella sopravvive al di là della storia, e sana le ferite delle colpe educando la libertà.
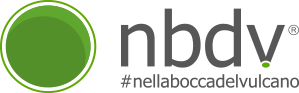









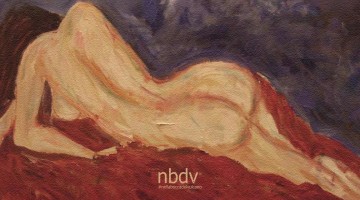
Nessun Commento